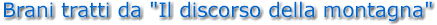
Il "comandamento dell'amore" in tutta la sua ricchezza e profondità nell'humus
giudaico
Pinchas Lapide, Paideia, 2003

Pinchas Lapide (1922-1997), console d'Israele a Milano negli anni '60, è stato una grande
figura di esegeta neotestamentario ebreo, che molto si è adoperato per il dialogo ebraico cristiano. Il suo libro «Il
discorso della montagna» - ritraducendo il greco del testo neotestamentario nella lingua d'origine - ricostruisce
l'ambiente storico e spirituale in cui venne pronunciato il più dirompente dei discorsi di Gesù e fornisce una versione
inedita delle beatitudini evangeliche. Ne pubblichiamo alcuni brani significativi che mostrano consistenza e attualità
soprattutto in momenti di crisi quali quelli che stiamo oggi attraversando. Da essi emerge con grande chiarezza la
connessione inscindibile tra ebraismo e cristianesimo, nonché la continuità e novità dell'insegnamento di Gesù

Il giudeo Gesù
torna
su
Per me Gesù non è tanto il fondatore del cristianesimo quanto il fautore di
un'esistenza cristiana che nel discorso della montagna ha il suo grande manifesto; un'esistenza cristiana che in
fondo è pari a un'esistenza ebraica di fede, anche perché purtroppo entrambe non hanno trovato che pochissimi
imitatori.
Ecco dunque in Israele un uomo alzarsi in piena notte per fare della visione
profetica l'ordine del giorno dell'indomani, uno cui le direttive del monte Sinai non bastano più
perché vuole
riscoprire l'intento originario di Dio. Nonostante la guerra e la tirannia, egli per fede osa portare fino alle
estreme conseguenze il comandamento biblico dell'amore per il prossimo, imprimendo nell'anima di tutti l'immagine
indelebile e ideale di un'umanità possibile, un'immagine che non consente più a nessuno di accontentarsi di un
uomo debole e mediocre, di uno che è esattamente come noi ma non deve esserlo.
È un ideale realizzabile, un'utopia realistica che non deve rimanere sulla
carta se l'ebreo credente trova il coraggio di superare se stesso, di andare oltre se stesso per diventare più
grande e più umano, nell'instancabile imitazione di Dio che nell'ebraismo è considerata il più santo dei
comandamenti. In questa grande spinta messianica verso l'incarnazione voluta da Dio di tutti i figli di Adamo e
verso l'umanizzazione di questa terra, nell'imperitura potenza della speranza che dalla fiducia «dall'alto»
attinge il coraggio per andare «avanti», Gesù di Nazaret è stato «l'ebreo centrale», come lo definisce Martin
Buber, colui che ci invita tutti a imitarlo.
«Chi incontra Gesù Cristo incontra l'ebraismo». Così esordisce la
dichiarazione del 28 aprile 1980 dei vescovi cattolici della Repubblica Federale Tedesca, «Il rapporto della chiesa
con l'ebraismo», affermazione che anche il papa ha fatto propria durante la sua visita a
Magonza.
Ciò che traspare inequivocabilmente da queste parole è che l'appartenenza di
Gesù al popolo d'Israele non si limita a quella strettamente biologica, ma emerge in particolare nel suo mondo
spirituale e nel suo patrimonio di fede.
Questa circostanza ha come conseguenza ineluttabile che tutto ciò che Gesù
ha detto, fatto, compiuto o trascurato appare nel suo significato più pieno solamente se si è in grado di
coglierlo partendo dal suo essere profondamente ebreo.
A ciò si accompagna una seconda convinzione, che proviene da Martin Lutero.
Nei Discorsi a tavola I leggiamo: «La lingua ebraica è la migliore, la più ricca di parole; essa è pura e
non va a mendicare, ha un suo colorito, tanto che nessuno è in grado di imitarla... Se fossi più giovane mi
piacerebbe studiare questa lingua, perché senza di essa è assolutamente impossibile comprendere rettamente la
Scrittura. Il Nuovo Testamento, infatti, sebbene sia scritto in greco, è pieno di ebraismi e di modi di dire
ebraici. Perciò è stato detto con ragione che gli ebrei bevono dalla sorgente originaria, mentre i greci bevono
dai rigagnoli che dalla sorgente si dipartono; i latini, infine, bevono dalle pozzanghere».
L' essere giudeo di Gesù e l' ebraicità di fondo della sua lieta novella
siano il duplice criterio che ci consenta di scoprire, sotto il greco di traduzione dell'evangelista, quanto più
possibile il significato originario del capolavoro dell'etica di Gesù.
[...]
Se dunque vogliamo servire questa verità, occorre stabilire una volta per
tutte che con il suo divieto di non prestare giuramento Gesù non ha prodotto nulla di nuovo, e che non si può
parlare di antitesi né di supertesi. Siamo invece di fronte a un’altra prova del fatto che il rabbi di Nazaret
poggiava saldamente e con entrambi i piedi su basi rabbiniche.

Il diritto
superiore torna
su
Le ultime due supertesi, riguardanti la rinuncia alla resistenza e l'amore per
il prossimo, dal punto di vista contenutistico appartengono al medesimo genere, come una doppia corona in cima al
programma normativo di Gesù per I'umanizzazione di questo pianeta voluta da Dio.
Chi prende in esame tutta quanta la storia universale può distinguere tre
epoche principali nel corso della convivenza umana. L'uomo inizia la sua carriera sotto il predominio della
violenza, la quale della coesistenza fece una convivenza utilitaristica di legittima difesa, allo scopo di garantire
la pura e semplice sopravvivenza.
Lungo e sanguinoso fu il cammino dal diritto del più forte a quello della
parità, che non guarda all'aspetto della persona ma proclama «uguale giustizia per tutti». Eppure anche questa
giustizia duramente conquistata, che divenne un principio astratto per soffocare pregiudizi di parte, come tutte le
teorie può tramutarsi in ingiustizia capace di portare all' odio, alla collera e alla guerra. In ultima analisi,
anch'essa per imporsi ha bisogno del potere dello stato.
Si giunse così alla convinzione che la vera giustizia necessita di una più
profonda dimensione giuridica, acciocché il diritto possa diventare vero diritto. Da essa ebbe origine la tsedaqa
ebraica che mette la misericordia davanti alla giustizia, poi che accorda
al prossimo quella priorità che solo l'amore è in grado di dare. È il riconoscimento, pieno di speranza, che non
è sufficiente passare dallo scontro brutale (l'uno contro l'altro) alla coesistenza indifferente (l'uno accanto
all'altro), perché è nel destino dell'uomo avanzare verso la convivenza feconda (l'uno con l'altro), la
quale può culminare nel servizio amorevole (l'uno per l'altro).
Questo concetto di fondo è ripreso da rabbi Samuel Raphael Hirsch, fondatore
della neo-ortodossia nella Francoforte del XIX secolo, allorche nell'interpretazione di Is. 53,8 sostiene l'idea che
il popolo ebraico è destinato a esercitare la sua influenza sul mondo delle nazioni attraverso l'assenza di potere
e la passività. Non devono più essere la proprietà e il potere i fattori determinanti delle nazioni e della
società, poiché a una politica della violenza deve subentrare una teopolitica guidata soltanto da principi etici,
così come sono espressi nell'ideale biblico della teocrazia dell'amore.(1)
A questo amore nonviolento, che può crescere fino a dominare completamente il
cuore, sostituendo i vecchi rapporti di potere con valori come servizio e fratellanza, è dedicata la parte centrale
dell'insegnamento della montagna.
Le tre richieste radicali di rinuncia alla violenza che lo costituiscono
culminano nel comandamento del cosiddetto «amore per i nemici», il detto di Gesù citato più spesso in tutto il
Nuovo Testamento, ma anche quello che è meno messo in pratica.
Poiché qui siamo di fronte all'affermazione cruciale dell'etica gesuanica,
che a buon diritto può essere considerata anche la pietra di paragone della «giustizia migliore», inaugureremo
con essa le nostre riflessioni.
«Avete inteso che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. E io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché diventiate figli del Padre vostro
nei cieli; egli infatti fa sorgere il suo sole sopra malvagi e buoni, e fa piovere sopra giusti e ingiusti» (Mt.
5,43-45).
La prima frase di questo celeberrimo passo racchiude una citazione biblica (Lev.
19,18) che altrove Gesù mette in risalto come «il più importante» o «il primo comandamento» (Mc. 12,29
ss.), in risposta alla domanda inquisitrice di uno scriba sulla fede di Gesù (Mc. 12,28).
Tuttavia, malgrado il duplice preambolo - «avete udito» e «che fu detto»
-, che nel linguaggio rabbinico serve sempre a introdurre una parola di Dio tratta dalla Torà, qui la frase
sull’amore per il prossimo viene ridotta fino a risultare persino alterata. L'evangelista dimezza infatti il
comandamento ebraico omettendo tanto il necessario termine di paragone «come te stesso», quanto la conclusione
«io sono (Dio) il Signore» (Lev. 19,18). Certamente Gesù non aveva tralasciato queste due espressioni,
perché chi dice «finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure una iota della Torà» (Mt.
5,18), sta molto attento a come usa la sacra Scrittura, che è parola di Dio.
Purtroppo queste omissioni di testo non solo mutilano un passo notissimo della
Bibbia, che svariati padri del Talmud definiscono kelal, «chiave», per la Torà, ma defraudano anche
l'amore per il prossimo della sua componente verticale in cui ha sede il suo fondamento teologico. Infatti l'amore
per il prossimo può essere spiegato in modo convincente solamente a partire dall'idea dell'unità di Dio, come è
dimostrato dalla teo-logica dei rabbi: perché l'amore per il prossimo non degeneri in utilitarismo meramente
orizzontale, in un'empia accolita di egoisti, magari anche lungimiranti ma pur sempre senza fede, è necessaria la
conclusione «Io sono (Dio) il Signore». Infatti solamente sotto la paternità comune di Dio l'amore per il
prossimo in quanto comunità di simili riceve senso e significato.
Joseph Albo, uno dei massimi filosofi della religione del tardo medioevo,
afferma che l'unicità di Dio e il suo amore sono indissolubilmente uniti, e basa quest'affermazione sul fatto che
le due parole ebraiche 'ahaba (amore) e 'ehad (unico) possiedono lo stesso valore numerico di tredici.
Ma tredici è il numero degli attributi di Dio quando si rivela (Es.34,6-7), per cui tutte le sue qualità
sono racchiuse nell'essenza del libero e immeritato amore misericordioso.
Ma l'esclusione arbitraria di «Dio, il Signore» dall'amore per il prossimo
elimina anche la formula, necessaria ai fini dell'argomentazione, che introduce la conclusione culminante di Gesù:
«Affinché diventiate figli del Padre vostro nei cieli!», laddove il termine «figli», in ebraico, può designare
non solo i discendenti diretti ma spesso anche i collaboratori, i seguaci o gli emulatori.
Il redattore greco, molto probabilmente, ha omesso tutto ciò per inserire in
un logion di Gesù - come una stoccata antiebraica - l'odio per il nemico, che oltre a essere contrario alla Bibbia
qui è proprio fuori luogo.
Ma torniamo nuovamente alla citazione ridotta, che certo Gesù aveva
presentato nella sua versione originale: «Ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono Dio, il Signore» (Lev. 19,18).
Così riportano praticamente tutte le edizioni in tedesco della Bibbia dopo
Martin Lutero, anche se il primo sostantivo non viene reso in modo del tutto esatto. «Il prossimo», infatti, è
termine che non rende del tutto giustizia né al greco  (o plesίon), che designa «il vicino» o «ciò
che sta vicino», né all'ebraico rea' che gli è alla base, rea' in quanto «compagno» è, come ha
illustrato Buber, la persona con cui sto avendo a che fare, colui che mi sta appunto di fronte. Dunque la persona
che in questo momento mi sta affrontando, non importa se sia un mio consanguineo oppure un completo estraneo.
(o plesίon), che designa «il vicino» o «ciò
che sta vicino», né all'ebraico rea' che gli è alla base, rea' in quanto «compagno» è, come ha
illustrato Buber, la persona con cui sto avendo a che fare, colui che mi sta appunto di fronte. Dunque la persona
che in questo momento mi sta affrontando, non importa se sia un mio consanguineo oppure un completo estraneo.
Leggendo all'interno della «legge di santità» (Lev. 19, 9-18) la
sezione da cui Gesù trae la sua citazione, si noterà subito che la missione di santificare il mondo che qui Dio
affida ha come obiettivo principale una migliore convivenza degli uomini.
Da Lev. 19 emerge anche chiaramente che tutti coloro che hanno sete di
amore sono tra i primogeniti di Dio, non importa a quale popolo appartengano. Si tratta del povero, del forestiero,
del lavoratore a giornata, del sordo, del cieco e del misero: devono essere tutelati da ogni tipo di svantaggio,
denigrazione, discriminazione o insulto, perché «lo sono il Signore, vostro Dio», come si ripete per cinque volte
come motivazione. Significa: io sono il creatore di ogni tipo di vita, e amo i poveri e i miseri esattamente come
amo voi, che per amore ho liberato dalla miseria della schiavitù egiziana, affinché attraverso l'esperienza del
dolore possiate imparare la lezione d'amore e diventare così il mio popolo, esempio per tutti gli altri
popoli.
Quando poi tutte queste disposizioni per l'edificazione di una comunità umana
culminano nel compendio: «Ama il rea' in quanto prossimo con cui hai a che fare!», allora significa anche
che qui l'amore non è solamente una relazione a due, bensì un'attitudine di fondo che riguarda tanto Dio, colui
che ha instillato in voi tutti la capacità di amare, quanto la società che avete il compito di innalzare a una
superiore comunità di vita per mezzo di piccoli passi amorevoli.
La pietra di paragone per questo tipo di sensibilità capace di promuovere la
giustizia è il forestiero, colui che parla, pensa e crede in modo diversissimo da noi, sfidandoci così a essere
generosi, «poiché se porgete la pace solamente ai vostri fratelli, che cosa fate di tanto straordinario? Non fanno
così anche i pagani?» (Mt. 5,47), come ribadiscono a una voce Gesù e i rabbi.(2) Sta scritto infatti
chiaramente: «... poiché il Signore vostro Dio è... il grande Potente e il terribile Dio, che non usa riguardo
alla persona... e ama il forestiero» (Deut. 10,17 s.); perciò «amerai lo straniero come te stesso» (Lev.
19,34).
Lo amerai, perche ha bisogno d'amore proprio come te, che necessiti di questo
amore per vivere, come ti ripete ogni giorno il tuo cuore. Nella Bibbia, il suo essere-come-te risulta rafforzato
dal tuo soffrire-come-lui: «Anche voi conoscete il cuore del forestiero, perché anche voi siete stati forestieri
in Egitto!» (Es. 23,9).
In parole povere, avendo già sperimentato abbastanza che cosa significa la
mancanza d'amore, sapete bene ciò a cui anela il cuore. Quando eravate schiavi sottomessi avete vissuto sulla
vostra pelle quanto sia necessario andare incontro all'altro con amore, poiché solamente chi è stato forestiero
provato dal dolore ha appreso quanto l'odio possa rendere spaventosamente inumani; l'amore invece è in grado di
sanare e di condurre a un'umanità più profonda sia chi lo dona sia chi lo riceve. Meta e obiettivo dell'appello
alla bontà lungo un intero capitolo (Lev. 19) è fare sì che lo straniero nell'Israele biblico non si trovi
nelle condizioni di Israele quando era in Egitto; ovunque, infatti, vi sono «Egitti». Ma Canaan, la terra dei
pagani, grazie alla giustizia dell'amore praticata (tsedaqa) è destinata a diventare la terra promessa, che
alla fine includerà l'intero pianeta.
Per questo nella legge di santità è detto espressamente: «Quando un
forestiero dimorerà presso di voi, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante tra di voi sia come uno che è nato
tra di voi» (Lev. 19,33 s.). Non basta dunque ribadire che il rea' comprende anche chi è forestiero,
in quanto proprio lo straniero fu all'origine del comandamento dell'amore. Solamente nel momento in cui lo straniero
sospetto poté essere promosso a fratello, nell'Israele biblico l'amore per il forestiero divenne il metro di misura
dell'amore universale per l'uomo.
In origine il rea' era il vicino di pascolo, e in quanto tale può
trattarsi anche di un egiziano (Es. 11,2), colui che un tempo era il tiranno. Dunque non è affatto solo «il
prossimo», «il più vicino», superlativo che esprime un'estrema vicinanza spirituale, confessionale o etnica, ma
- rispetto alle sue caratteristiche personali - può essere anche il più lontano, che però adesso sta di fronte a
te come tuo fratello.
D'altra parte «il prossimo», colui che per legami di sangue o per ragioni di
spazio fisico è il più vicino a te, potrebbe anche essere il tuo nemico peggiore, per cui la sua stessa vicinanza
eccessiva lo rende insopportabile.
«Chi è il mio rea'?». A questa domanda, che Luca pone sulle labbra
di un dottore della legge (Lc. 10,29), i rabbi, come usa nel giudaismo, rispondono con un'altra domanda:
perché Dio ha creato un solo Adamo? Forniscono poi anche la risposta: a motivo della pace tra i popoli. Nessun
figlio di Adamo, infatti, potrà mai dire al suo vicino: il mio sangue scorre più rosso (o più blu) del tuo nelle
mie vene! Affinché non sorgano orgoglio o superbia razzisti il creatore ci ha dato un capostipite comune. E
affinché nessuno possa sostenere che ci sono molte potenze nei cieli, perché l'unità di fondo dell'umanità è
già di per sé una dimostrazione dell'unicità del suo creatore, come pure l'uguaglianza di tutti i figli di Adamo,
che senza eccezione vengono tutti al mondo nella nudità, e nella medesima condizione fanno tutti ritorno alla
terra.
Da questa condizione di uguaglianza dell'inizio e della fine di ogni essere
umano, voluta da Dio, nasce non solo la democrazia dell'universale parità di diritti e la pluralistica libertà
religiosa nel giudaismo, ma anche il medesimo diritto alla salvezza da parte di tutti i figli di Dio. Nessuno che
sia fatto a immagine di Dio è privo di salvezza, o privo di amore, o non amato! È questo il lieto annuncio della
Bibbia ebraica, che si deve irrefutabilmente ricavare dall'unità assoluta di Dio.
Non basta! La testimonianza più eloquente della grandezza di Dio è resa
dalla molteplicità con cui egli ha creato gli uomini, una molteplicità tale che persino i gemelli sono differenti
l'uno dall'altro -eppure non esistono uomini di specie diverse, ma solo la grande famiglia della discendenza di
Adamo, nella quale tutti, nella loro unicità individuale, godono degli stessi diritti, sono radicati nella stessa
terra, aspirano al medesimo cielo, condividono il medesimo destino dell'uomo e sono egualmente amati dal loro
creatore.
E chi può odiare colui che Dio ama? Per dirla come rabbi Natan: «Chiunque
odia il suo rea' sradica Dio da questo mondo» (Abot de-r. Natan 30). Perciò pochi rabbi soltanto
approvano la limitazione dell'amore per il prossimo, come consiglia invece Paolo: «Facciamo il bene a tutti, ma
soprattutto ai fratelli nella fede!» ( GaI. 6, 10). La Bibbia di Gesù non riconosce diritti particolari a
nessuno, nessuna priorità di questo tipo. Essa impone di «amare come te stesso» il rea' (Lev. 19,18) anche
se è uno straniero (Lev. 19,34).
Secondo Ezechiele (47,21-23) i forestieri hanno diritto a partecipare alla
spartizione del paese. Possono comprare schiave e schiavi ebrei. Giuridicamente hanno pari diritti rispetto ai
nativi. Uno degli oracoli di minaccia nel Deuteronomio enuncia: «Sia maledetto chi lede il diritto del forestiero,
dell'orfano e della vedova!» (Deut. 27,19).
Le sei città di asilo in cui si può rifugiare chi abbia commesso un omicidio
involontario - una delle istituzioni mosaiche per contrastare la vendetta di sangue - sono aperte anche a loro (Num.
35,16). Da loro non si possono esigere interessi sui prestiti, né offrirli - così è scritto in Lev. 25,35-37,
in cui il forestiero viene definito «fratello».
Che questo fratello possa essere anche il pagano e l'adoratore di idoli è
ripetuto spessissimo, ad esempio nella spiegazione di Lev. 19,13: «Non opprimerai il tuo rea'! Il
tuo rea' è tuo fratello; tuo fratello è il tuo rea'. Da ciò si apprende che rubare a un pagano è
rapina. E non si può intendere in senso restrittivo 'solo il tuo prossimo', perché si intende ogni uomo» (Seder
Eliahu rabba 49).
Del re Giosia, Geremia dice in nome di Dio:
Egli praticava il diritto e la giustizia
tutelava la causa del misero e del povero.
Questo non significa conoscermi ?
Dice il Signore (Ger. 22,16).
Così facendo il profeta equipara decisamente l'assistenza che viene prestata
agli indifesi - chiunque essi siano - alla conoscenza di Dio.
Queste dichiarazioni e altre analoghe non sono certo improntate a sciovinismo
né a xenofobia -per non parlare di odio per il nemico -; se ne può anzi ricavare un universalismo illimitato della
parità di diritti di respiro messianico. Del prossimo è detto infatti: «Non odierai il tuo fratello nel tuo
cuore!» (Lev. 19,17). In questo modo non si proibisce solamente l'ostilità effettiva, ma anche emozioni come
l'invidia, il desiderio di vendetta, la gelosia o l'invidia, tutti sentimenti che corrompono il cuore, dato all'uomo
per amare.
Questo rea " dunque, è colui che non è affatto vicino, in tutta
la sua diversità voluta da Dio, e che ci viene incontro quando è importante essere un vero essere umano. Per
volontà di Dio, infatti, ciò può avvenire solo in due, nella divisione e nella condivisione di quell'amore che
egli ha instillato in ciascuno di noi. Poiché se si guarda a fondo l'essere umano non è un essere singolo, ma una
creatura di dialogo che necessita del rea' per riuscire a far sbocciare pienamente l'umanità che in germe è
dentro di lui. Scolpito indelebilmente, nel piano della creazione sta scritto che ogni io ha bisogno di un tu per
crescere, maturare e diventare adulto nella sua umanità. Questo rea', questo «altro», è però sempre
anche il concreto, imprevedibile abitante della terra che ci viene incontro - o con cui ci confrontiamo, o
addirittura non ci incontriamo nemmeno, circostanza che non ci esime dal dovere dell'amore.
Se infatti diventi l'avversario del tuo avversario, rinunci al meglio di te
stesso solamente per appropriarti del peggio dell'altro. Ma la fedeltà verso te stesso esige che la precedenza
spetti al tuo metro di misura, malgrado l'influsso malevolo proveniente dall'esterno. In caso contrario vai fuori
strada, smarrisci l'autodeterminazione e ti abbandoni all'odio, che è in totale contraddizione con l'operato di
Dio.
Come dice rabbi Meir: «Dio dice: Sii simile a me! Come io ricompenso il male
con il bene, così anche tu il male con il bene!» (Es. rabba 26,2 a 17,8).
II posto centrale che l'amore per il prossimo così inteso occupa
nell'ebraismo come culto efficace è testimoniato dalla grande varietà di interpretazioni della massima, tratta da Lev.
19 e citata anche da Gesù.
L'interpretazione hassidica afferma: «Ama il tuo prossimo come te stesso; io
sono il Signore». II significato più profondo di queste parole è che ovunque nel mondo due persone si amino
disinteressatamente, là Dio è il terzo nella loro unione.
Raccontava Martin Buber che una volta, dopo una conferenza a Francoforte
sull'amore per il prossimo, una signora lo interpellò chiedendo: «lo non amo affatto me stessa, signor Buber, come
posso dunque amare il mio prossimo?». Buber e Rosenzweig, che all'epoca erano impegnati nella traduzione in tedesco
della sacra Scrittura, presero sul serio questa domanda e andarono a interrogare il loro testo biblico, incappando
nella possibilità di una traduzione diversa che comunque non tradiva né il tenore né il significato originario.
Alla fine scrissero: «Abbi caro il tuo compagno, uguale a te!».
Quando chiedemmo che cosa ci avevano guadagnato, Buber rispose: «Con questo
si afferma che il tuo prossimo, per quanto grande, brutale o spietato possa sembrarti, è come te debole, fragile,
caduco ed esposto a tutte le angosce della vita. Questo essere-come-te disarma così qualsiasi paura tu possa
nutrire nei confronti del tuo rea '. Ma non appena alla paura si toglie il terreno da sotto i piedi, ecco che
anche l'odio, che quasi sempre scaturisce da una paura subliminale, diventa anch'esso inconsistente e vano.. E non
appena la paura e l'odio scompaiono, ecco che i battenti del cuore si spalancano all'amore per il prossimo, libero e
senza impedimenti». Un giorno i discepoli chiesero al rabbi di Slozow: «Nel Talmud è scritto che il nostro padre
Abramo ha compiuto tutta la Torà. Come è possibile questo, se a quell'epoca essa non era ancora stata data?».
Il rabbi rispose: «Non bisogna fare altro se non amare Dio e le sue creature!
Se vuoi fare qualcosa e ti accorgi che potrebbe diminuire il tuo amore, allora sappi che è peccato; se vuoi fare
qualcosa e ti accorgi che il tuo amore ne risulterebbe moltiplicato, sappi che la tua volontà è conforme alla
volontà di Dio. Così pensava anche il nostro padre Abramo».
Rabbi Joshua Heschel, uno dei maggiori filosofi delle religioni del nostro
secolo, diceva: Ama il tuo prossimo; egli è come te. Che cosa vuole insegnarci il Creatore con queste parole? Rabbi
replicò: Dio dice: Io vi ho creati entrambi come portatori della mia immagine, cosicché ogni odio per il prossimo
non è altro che odio mascherato per Dio. Se serbi rancore al tuo prossimo per qualcosa, se lo insulti, se lo
detesti o lo disprezzi, in realtà fai tutto questo alla scintilla divina che arde nel suo cuore conferendogli la
nobiltà della natura umana.
I mistici della cabala medievale usavano dire: Il prossimo è sempre una parte
di te; in ogni altro uomo ci sei anche tu in embrione; il non amore per il prossimo si vendica sul proprio ego, che
grida al cielo contro il masochismo della mancanza d'amore. Perché a ben guardare ogni odio è odio di sé. Ogni
dimostrazione d'amore in fondo è un servizio all'io; l'altruismo, perciò, non è altro che egoismo illuminato, che
sviluppa sufficiente fantasia da «uscire dalla pelle» per introdursi nella pelle dell'altro, percependone la
sofferenza e alleviandola - come se si trattasse di un pezzetto di te.
Persino Max Horkheimer, l'eretico ebreo credente, conferma lo stesso pensiero
fondamentale: «Visto dalla prospettiva del positivismo... l'odio non è peggiore dell'amore... Senza il richiamo a
un qualcosa di divino la buona azione perde il suo significato... Con l'ultima traccia della teologia, l'idea che il
prossimo sia da rispettare e amare perde il suo fondamento logico».

Comandamento dell'odio per il
nemico? torna
su
Alla citazione frammentaria di Mt. 5,43 relativa al cosiddetto «amore
per il prossimo» fa subito seguito l'accenno a un comando di odio per il nemico che è impossibile possa provenire
da Gesù in persona. Si tratta del singolare imperativo «odia il tuo nemico!», che smentisce l'ethos di
tutta quanta la Bibbia.
La supposizione recentemente formulata - secondo la quale questo «odio per il
nemico» si riferirebbe alla regola della setta di Qumran (1QS 1,3 s.) dove si parla di «odio contro tutti i figli
delle tenebre» (cioè tutti gli avversari dell'ordine) - sembrerebbe un po' tirata per i capelli, in quanto
entrambe le introduzioni «avete inteso» e «è detto» vengono usate sia nel discorso della montagna sia nella
letteratura rabbinica per introdurre tradizioni bibliche.
All'epoca di Gesù la setta di Qumran era ancora troppo recente, troppo
distante e troppo piccola per poter essere considerata in Galilea una norma - o un'antinorma - conosciuta.
Ciò ha nel frattempo incontrato il consenso generale. Un esempio per tutti è
qui fornito dalla cattolica Bibbia di Gerusalemme che, a proposito dell'odio per il nemico che a quanto pare
verrebbe imposto, riconosce: «La seconda parte di questo comandamento... non si trova, tale e quale, nella legge
né si potrebbe trovare».(3)
Ancor più esplicito è Ethelbert Stauffer che per la sua famigerata
degiudaizzazione di Gesù, al tempo di Hitler poteva considerarsi al di sopra di ogni sospetto di filosemitismo:
«Da sempre la sinagoga ha giustamente protestato contro Mt. 5,43. Non esiste una legge che prescriva l'odio
per il nemico, né nell'Antico Testamento né nel Talmud.
Non è improbabile che qui Gesù sia ricorso al verbo ebraico «odiare» nella
sua seconda accezione, molto meno forte, e che ci è nota attraverso due dei suoi logia.
Riguardo alle condizioni per seguirlo Gesù dice ai discepoli: «Se uno viene
a me e non odia suo padre e sua madre, sua moglie e i suoi figli, e persino la sua stessa vita, costui non
può essere mio discepolo» (Lc. 14,26). Riguardo alla dinamica morire-divenire, nel discorso di commiato
afferma: «Chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv. 12,25).
Qui il verbo «odiare» ha il significato biblico di stimare poco, amare meno,
come ad esempio nell'oracolo di Dio: «Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù» (Mal. I, 2-3 e Rom. 9,13).
Il medesimo significato si evince dal passo che si riferisce all'uomo con due mogli, «una che egli ama, e una che
odia» (Deut. 21,15). A questo proposito il Talmud pone la domanda retorica: « Vi sono forse davanti a Dio
gli amati e gli odiati ?» Jebamot 23a).
Questa lettura meno drastica dell'intento dichiarativo di Gesù non è certo
da respingere, tuttavia sia la tradizione biblica a cui qui ci si riferisce, sia il contesto interno di questa
supertesi non appoggerebbero questa eventualità. Sembrerebbe dunque più opportuno attribuire quest'affermazione
denigratoria al redattore finale di Matteo, il quale non si lascia sfuggire occasione per inserire nel suo originale
battute polemiche e frecciate antigiudaiche. Questa ipotesi trova sostegno anche nel parallelo lucano del cosiddetto
discorso della pianura, dove questo «odio» non riceve menzione alcuna.
Il sentimento opposto all'odio per il nemico è molto più familiare
all'ebraismo. Hillel il Saggio, che molti studiosi considerano uno dei maestri del giovane Gesù, insegnava ai suoi
discepoli: «Annovera tra gli scolari di Aronne colui che ama la pace e aspira alla pace, colui che ama le creature
e fa loro conoscere la Torà» (Abot l, 12), affermazione che include chiaramente sia l'amico sia il nemico.
Nei Proverbi di Salomone è scritto: «Non rallegrarti per la caduta del tuo
nemico, e se egli soccombe non gioisca il tuo cuore!» (Prov. 24,17). Dal versetto i rabbi traggono questa
conclusione: «Nella Scrittura sta scritto per tre volte che in occasione della festa delle capanne bisogna gioire (Deut.
16,14 e 15; Lev. 23,40). Ma per la festa della pasqua, sebbene essa celebri la liberazione del popolo, la
gioia non è menzionata in nessun passo della Scrittura. Perché? Perché in tale occasione hanno perso la vita gli
egiziani «nemici» (Pesiqta rab Kahana 189a). Neppure tra le accuse che Giobbe formula contro se stesso
manca questo problema di coscienza: «Ho gioito forse della disgrazia di chi mi odia e ho esultato perché lo ha
colpito la sventura? No, io non ho permesso alla mia bocca di peccare maledicendo la sua anima con una
imprecazione!» (Giob. 31,29 s.).
Qui è detto chiaro e tondo che il nemico è proprio colui che mi odia, dunque
il mio nemico soggettivo, che oggi è mio avversario ma domani non deve esserlo più; e comunque egli non cessa di
essere il mio rea', neppure se agisce male nei miei confronti. Sta scritto infatti: «Non vendicarti e non
serbare rancore!» (Lev. 19,18). E più chiaramente ancora: «Non dire: voglio ricambiare il male! Confida
nel Signore ed egli ti aiuterà» (Prov. 20,22).
Salomone ripete per chi è duro d'orecchi: «Non dire: come ha fatto a me
così io farò a lui; io renderò a ciascuno come si merita» (Prov. 24,29). E se poco più avanti è detto
(25,22): «Il Signore ti ricompenserà», i rabbi leggono in modo diverso l'ultimo verbo (jashlim invece di jeshalem)
spiegando così l'aggiunta: «II Signore lo porterà alla pace con te» (Midrash Prov. 25,22). E a
proposito dei nemici mortali di Israele nella Bibbia si dice: «Non avrai in abominio l'idumeo; è tuo fratello. Non
disprezzerai l'egiziano, perché tu sei stato forestiero nel suo paese» (Deut. 23,8).
In qualità di viceré d'Egitto, Giuseppe dice ai suoi fratelli contriti: «
Voi avevate pensato di farmi del male, ma Dio ha pensato di farlo diventare un bene»; questo «bene» riceve
immediatamente una spiegazione: «per mantenere in vita un popolo numeroso» (Gen. 50,20), espressione che si
riferisce agli egiziani stessi.
Nella letteratura rabbinica l'universalità dell'amore per il prossimo spesso
include esplicitamente «colui che odia»: «Non dire: amerò coloro che mi amano, e odierò coloro che mi odiano,
ma ama tutti!» (Testamento di Gad 6).
A questo divieto di rivalsa i rabbi associano l'esaltazione dell'umile
padronanza di sé, che pongono sullo stesso piano dell'amore per Dio: «Riguardo a coloro che vengono umiliati e non
umiliano, che ascoltano le loro ingiurie e non rispondono, che agiscono per amore e gioiscono per il castigo, di
costoro è detto (Giud. 5,31): 'Coloro che amano Dio sono come il sorgere del sole nel suo splendore'» (Joma
23a; Gittin 36b).
Poiché ogni rivalsa prende a modello del proprio agire il comportamento
altrui, in fondo a soffrirne sono due esseri fatti a immagine di Dio: tu e tuo fratello. La conclusione è evidente:
«Quanti vengono tormentati e non tormentano; odono la loro infamia e non ribattono; agiscono per amore e si
rallegrano per il dolore, sono questi ad amare Dio!» (Shabbat 88b). Tuttavia, poiché «colui che odia» non
può restare eternamente un nemico, ma potrebbe essere semplicemente vittima di un sentimento involontario, mutevole
come tutte le cose umane, rabbi Natan ne trae questa conseguenza costruttiva:
«Chi è l'eroe più grande del paese?». Egli stesso risponde a questa sua
domanda pedagogica: «Colui che conquista l'amore del suo nemico» (Abot de-r. Natan 23). Non si tratta certo
di qualcosa al di fuori della portata dell'uomo, come ribadiscono i rabbi osservando che la differenza tra
«nemico» ('ojeb) e «amante» ('oheb) risiede in un'unica lettera. La domanda è: perche non
dovremmo riuscire a trasformare uno jod in un he ?
Infine l'intimidazione rabbinica - pienamente in linea con Gesù - ammonisce:
«Chi odia il suo rea' fa parte di coloro che spargono il sangue» (Derek ' Eres rabba II).
Un esempio per tutti chiarisce come vadano tradotti nella pratica quotidiana
principi così elevati: interpretando Es. 21,1 s. il Talmud stabilisce che si deve salvare il ladro che si
introduce nottetempo in una casa e che per sventatezza finisce in pericolo di vita, anche se così facendo si deve
profanare il sabato (Sanhedrin 72b). Rabbi Nehonja insegnava a pregare ai suoi discepoli: «La tua volontà
sia... che non nasca nel cuore di nessun uomo l'odio per noi, che nessuno sia geloso di noi e che noi non siamo
gelosi di nessuno... e che tutte le nostre opere siano a te gradite come suppliche» (jBerakot 4,7d). Di
spirito analogo, la preghiera di Mar Bar Rabina è talmente significativa da meritare di essere ripetuta ancora oggi
per ben tre volte durante la liturgia sinagogale: «Mio Dio, proteggi la mia lingua dal demonio e le mie labbra dal
proferire inganni. E nei confronti di coloro che mi maledicono, ammutolisci la mia anima, e la mia anima sia come
polvere per tutti» (Berakot I7a). Che non ci si accontenti della preghiera è testimoniato da un veterano di
guerra giudaico del primo secolo: «Bisogna trattare con bontà anche il nemico (sconfitto)», sostiene Giuseppe per
esperienza propria (Contra Apionem 2,28,209).
Ma l'aiuto, l'assistenza e la premura per il nemico compaiono già nel primo
libro di Mosè: Abramo prega per Abimelek, il re di Gerar, che gli aveva portato via la moglie Sara (Gen. 20,17),
e implora la guarigione del suo avversario. Giuseppe perdona i fratelli, che lo avevano venduto come schiavo, «li
consolò e parlò amichevolmente con loro» (Gen. 50,18-21).
Per cinque volte Mosè prega per la prosperità del faraone e degli stessi
egiziani, che avevano tenuto sottomesso per secoli il popolo d'Israele e infine avrebbero voluto annientarlo: «Il
faraone disse: Vi lascerò partire ..., ma non andate troppo lontano e pregate per me! Mosè rispose: ...Pregherò
il Signore perché domani i mosconi si ritirino dal faraone e dal suo popolo... E il Signore fece come aveva pregato
Mosè» (Es. 8,24-27). Solo che per l'ennesima volta il faraone lo ingannò, poi chiese perdono, e dopo
l'eliminazione di ciascuna delle prime nove piaghe regolarmente ruppe la parola data: ciò nonostante Mosè fece
intercessione per lui e per il suo popolo, e venne ascoltato.
Giobbe, provato dalla sofferenza, prega parimenti per i falsi amici che gli
propinano ipocrite parole di consolazione, «e il Signore esaudì Giobbe» (Giob. 42,9).
La stessa cosa avviene per il giovane Davide, che risparmia il re Saul quando
lo ha tra le mani, inerme, sebbene più volte questi avesse cercato di farlo uccidere. «Io non ho peccato contro di
te», dice il pastorello al suo mortale nemico e sovrano, «tu invece mi dai la caccia per prendermi la vita» (1
Sam. 24,12). Che con questa sua magnanimità Davide non costituisse un'eccezione tra i sovrani d'Israele è
testimoniato dalla storia del re degli aramei Ben-Hadad, che combatte per anni guerre contro Israele finché il re
Acab riuscì a sconfiggerlo e a mettere in fuga il suo esercito. La narrazione prosegue così: «Ben-Hadad fuggì in
città e si nascose... Allora i suoi ministri gli dissero: Ecco, abbiamo sentito che i re della casa d'Israele sono
re clementi':.. Forse ti lascerà in vita... E si recarono dal re d 'Israele e dissero: Il tuo servo Ben-Hadad ti
manda a dire: Lasciami in vita! ...Ma Acab disse: ...Egli è mio fratello! ...Allora Ben-Hadad si recò da lui. E
Acab lo lasciò salire sul suo carro..., concluse con lui un'alleanza e lo lasciò andare» (1Re 20,30-34).
Dopo che Geremia ha inutilmente predicato nella sua città natale la pacifica
sottomissione a Nabucodonosor, re di Babilonia, la città santa viene distrutta, il tempio ridotto in macerie e «il
popolo che era rimasto nella città venne soggiogato come bestiame e deportato in prigionia» (2 Re 25,8
ss.).
Intorno all'anno 594 a.C. il profeta scrive «ai deportati», ai quali i
dominatori babilonesi chiedevano di «cantare e di gioire di cuore» (Sal. 137,3). «Cercate il meglio della
città (Babilonia) in cui vi ho fatto deportare!». Così parla Dio attraverso la sua bocca, per poi chiedere agli
esiliati di intercedere per i loro oppressori: «E pregate il Signore per essa! Dal suo benessere infatti dipende il
vostro benessere» (Ger. 29,7).
Gli eventi storici diedero ragione a Geremia: la preghiera degli esiliati
venne esaudita, e la diaspora babilonese conobbe uno dei maggiori periodi di fioritura nella storia ebraica.
Giustamente il sinodo regionale della Chiesa Evangelica in Renania nel
regolamento dell'11.1.1980 «Per il rinnovamento del rapporto tra cristiani ed ebrei» conclude: «Nella tradizione
ebraica e in quella cristiana l'amore di Dio abbraccia tutte le sue creature. In quanto immagine di Dio e suo
partner, l'uomo deve improntare il suo agire a questo modello divino». Nell'ebraismo e nel cristianesimo, perciò,
egli non può «sottrarre il suo amore al prossimo, neppure se questi è il suo nemico, perché anche il nemico è
una creatura amata di Dio. Non deve quindi stupire se nell'ebraismo già prima di Gesù, contemporaneamente a lui e
dopo di lui all'uomo si comanda di amare il suo nemico... Non è dunque giustificato affermare che soltanto Gesù,
'attraverso il precetto dell'amore per il nemico', avrebbe liberato da ogni limite il comandamento dell'amore per il
prossimo».
E comunque va sottolineato che, nonostante i numerosi paralleli e analogie
nella letteratura ebraica che allargano l'amore per il prossimo sino a includere anche i più distanti, e che
proclamano tutte le creature di Dio degne di amore, tuttavia non vi è nel patrimonio educativo ebraico un solo
comando esplicito riguardante l'amore per il nemico. Quindi l'imperativo «amate i vostri nemici!» nel linguaggio
dei teologi è un lascito strettamente gesuanico.
È forse diventato anche un atteggiamento pratico caratteristico dei
cristiani, come lasciano intendere numerose prediche e conferenze ? Cercando casi dimostrabili di amore per i
nemici, il teologo Ethelbert Stauffer ne ha trovati solo quattro: «Gesù stesso, che già in croce riusciva a
pregare: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!» (Lc. 23,34). Il martire Stefano, che muore
dicendo: «Signore, non imputare: loro questo peccato!» (Atti 7,60). Giacomo, fratello di Gesù, che
nell'ora della morte prega così: «lo prego, Signore, Dio, Padre, perdona loro perche non sanno quello che fanno».
L 'ultimo caso è più recente: «Il 20 ottobre 1958 la Grande Camera Penale
del Tribunale del Voivodato di Varsavia apre il processo contro il Gauleiter (4) Erich Koch. L' accusato viene
tradotto dal carcere di Varsavia. Il primo giorno di udienza Koch dichiara: 'Se sono ancora in vita lo devo
esclusivamente a una grande donna, la dottoressa della prigione, dott.ssa Kaminska'. La dott.ssa Kaminska è
ebrea».(5)
Volendo essere franchi, bisogna aggiungere che anche gli altri tre erano
ebrei! E non sono rimasti gli unici. Tanti sopravvissuti ai campi di concentramento hanno cercato scrivendo di dare
uno sfogo ai loro sentimenti repressi, e la breve poesia dell'ebrea Ilse Blumenthal Weiss ne è un chiaro esempio:
Non riesco a odiare
mi picchiano, mi prendono a calci.
Non riesco a odiare.
Posso solo espiare,
per te e per me.
Non riesco a odiare
mi strangolano.
Mi tirano pietre.
Non riesco a odiare.
Posso solo piangere
amaramente.
Ad Auschwitz, Jules Isaac, lo storico e pedagogo ebreo francese, perse la
famiglia intera. Ciononostante, nel 1947 con l'opera Jesus und Israel riuscì a porre la prima pietra di
un'intesa tra ebrei e cristiani. Fu proprio questo libro a indurre successivamente papa Giovanni XXIII - a
quell'epoca ancora nunzio a Parigi - a inserire il rapporto tra chiesa ed ebraismo nell'ordine del giorno del
concilio Vaticano II. L'ultimo capitolo del volume si conclude con una domanda aperta: «Il bagliore del forno
crematorio di Auschwitz è per me il faro che guida tutti i miei pensieri. Oh, fratelli miei ebrei, e anche voi,
fratelli miei cristiani, non credete che esso si confonda con un altro bagliore, quello della croce sul Golgota?».(6)
Leo Baeck è stato l'ultima grande mente del rabbinato tedesco. Per tre volte
gli fu offerta la possibilità di emigrare per mettere in salvo sé e la famiglia. Per tre volte rifiutò l'offerta,
che gli appariva come una fuga dalla sua missione. Volle rimanere con il suo popolo in qualità di maestro «finché
anche un solo ebreo rimarrà in Germania», come si narrerà in seguito in una storia del lager. Le SS lo
impiegarono come cavallo da tiro per tirare ogni giorno il carro carico dei secchi delle latrine.
Ciononostante, in baracche di legno, in magazzini o a cielo aperto, ogni sera
teneva conferenze su Platone e Kant, su Isaia, Giobbe e Gesù - un discorso della montagna, durato anni, proveniente
dal fondovalle dell'abbandono, che con fermezza testimoniava la buona novella di entrambi i testamenti: «Il nostro
Padre nei cieli non è morto - anche se uomini a sua immagine sono diventati dei bruti!». Quando i russi liberarono
il campo di concentramento di Theresienstadt, di cui fino all'ultimo egli rimase il fulcro spirituale, rabbi Baeck
faceva parte, per caso o per provvidenza, dei prigionieri - 9.000 su 140.000 - che riuscirono a sopravvivere agli
orrori del lager.
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!» (Lc. 23,34).
Così pregò un tempo per i suoi torturatori rabbi Jeshua sulla croce romana. Nel 1945 rabbi Baeck mise in campo
tutta la sua influenza personale per proteggere i sorveglianti e tutto il corpo di guardia da atti di vendetta e non
appena si fu ripreso spiritualmente e fisicamente, fu tra i primi a promuovere la riconciliazione fra tedeschi ed
ebrei. La sua preghiera, che risale ai primi anni del dopoguerra, non ha bisogno di commento:
«Sia pace agli uomini di cattiva volontà, e sia posta fine a ogni vendetta e
a ogni discorso di punizione e castigo... È impossibile misurare le atrocità; esse sono al di là di ogni confine
della comprensione umana, e innumerevoli sono i martiri... Perciò, o Dio, non misurare con la bilancia della
giustizia le loro sofferenze, per non imputarle ai loro boia chiedendone un conto terribile, ma agisci diversamente!
Accredita piuttosto ai boia e ai delatori e ai traditori e a tutti i malvagi e metti loro in conto tutto il coraggio
e la forza d'animo degli altri, il loro accontentarsi, la loro nobile dignità, il loro tacito impegnarsi malgrado
tutto, la speranza che non si dà per vinta, e il coraggioso sorriso che ha fatto asciugare le lacrime, e tutti i
sacrifici, tutto l'amore ardente, ...tutti i cuori tormentati e straziati che però sono rimasti saldi e sempre
fiduciosi, di fronte alla morte e nella morte, sì, anche le ore della debolezza più profonda... Tutto ciò, o Dio,
deve contare davanti a te come riscatto per il perdono della colpa, deve contare per una risurrezione della
giustizia - deve contare tutto il bene, e non il male. E che nel ricordo dei nostri nemici noi non siamo più le
loro vittime, non più il loro incubo e fantasma, ma piuttosto il loro aiuto, perché cessi il loro furore... Solo
questo si esige da loro e che noi, una volta che tutto sia finito, possiamo tornare a vivere come uomini tra uomini,
e che scenda di nuovo la pace su questa povera terra, sugli uomini di buona volontà, e che la pace scenda anche
sugli altri».(7)
Tutto ciò che ci ha lasciato Itzchaq Katznelson, ebreo credente, direttore
del ginnasio cittadino di Lodz, è una poesia intitolata Il dolore dell'ultimo ebreo. Essa fu scritta lungo
la strada per Maidanek sul retro di tre buste, e sebbene l'autore sapesse che la sua meta finale sarebbe stata la
camera a gas, non un pensiero di vendetta, non una parola d'odio uscì dalle sue labbra. Ciò che è riuscito a
trasmetterci suona piuttosto come una teologia della sofferenza espiatrice vicaria che irradia tutta la sua
grandezza d'animo. Ecco che cosa scrive:
Salito sulla croce è il mio popolo,
che espia per la colpa del mondo.
Se mai il mio è stato un popolo eletto
perché soffrisse per altri
allora adesso, allora adesso!
poiché non è ancora mai morto un ebreo
purificato come ciascuno di quelli che ci appaiono piccoli
a Varsavia, a Vilnius o a Wohlhynien.
Perché da ogni ebreo grida inorridito
un Geremia - ognuno è un asso quanto a delusione - che piange per tutti.
Durante la prima intervista rilasciata da Menachem Begin al giornalista
tedesco Hans-Joachim Schilde, che si svolse a Gerusalemme il 3 novembre 1978, al primo ministro fu chiesto: «Ma
dopo Auschwitz lei riesce ancora a credere in Dio?». Rispose: «Sì, ci riesco, perché Auschwitz è la nostra
offerta per la giustizia di Dio in questo mondo. Credo nella direzione di Dio nella politica. Se Hitler non avesse
sterminato gli ebrei, avrebbe forse vinto la guerra. Se non ci fosse la divina provvidenza, Hitler avrebbe costruito
per primo la bomba atomica... e in tal caso il nostro mondo sarebbe un unico immenso carcere. Sarebbe cominciata
l'era delle tenebre... In questa lotta per la sopravvivenza dell'umanità, noi ebrei abbiamo offerto il sacrificio
maggiore... Forse era il prezzo da pagare per non far vincere Hitler».
Il Salmo 109, attribuito a Davide, parla di nemici spietati. Il v. 4
proclama: «poiché io li amo, loro mi sono ostili; io però prego». Il midrash rabbinico applica questa
espressione al destino di dolore di tutto Israele: «Invece di amarmi, essi mi odiano», così dice Israele alle
nazioni. «Dovreste amarci, perché abbiamo offerto per voi settanta sacrifici nel tempio di Gerusalemme; ma voi non
ci amate, anzi, ci odiate; ciononostante noi preghiamo per voi!» (Midrash e Jalqut Shimoni su Sal. 109,4).
Se l'amore concreto per il nemico appartiene al cuore del cristianesimo,
allora talvolta mi è difficile capire chi sia più vicino a Gesù, se i fratelli carnali dell'ebraismo, oppure i
discepoli battezzati che provengono dal mondo dei gentili. (8)

(1) Gesammelte Schriften II, Frankfurt 1920, 187-202.
(2) Cf. Gittin 62a; Berakot 17a; jBerakot 8,12C.
(3) Bologna 1974, nota a Mt. 5,43.
(4) [Capo dell'organizzazione nazionalsocialista di un distretto].
(5) Die Botschaft Jesu,Bern 1959,146.
(6) Jesus und Israel, Wien 1968,463.
(7) Leo Baeck in Angst-Sicherung-Geborgenheit, di Th. Bevet, Bielefeld
1975
(8) Un esempio contemporaneo,
simile a quelli citati, può essere Padre Massimiliano
Kolbe, morto nel campo di Oswiipcim nel 1941 e, più recenti ancora, numerosi casi di
missionari uccisi in Africa [n.d.r]
