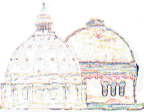|
|
LE RADICI EBRAICHE DI KAROL WOJTYLA |
|
È il Papa, il primo Papa dopo duemila anni, che è entrato in una sinagoga, compiendo così un gesto storico di riparazione e insieme di solidarietà verso i "Fratelli maggiori". |
 |
È il Papa che ha pronunciato le parole più dure, e per certi aspetti, bisognerebbe dire, parole definitive, sulla Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, e sulle rinascenti forme di antisemitismo, "peccato contro Dio e contro l'uomo". Il Papa che ha sanzionato, anche sul piano diplomatico, i rapporti che già da tempo si erano instaurati fra la Santa Sede e lo Stato di Israele. Ma è soprattutto il Papa che più ha fatto per "purificare" l'insegnamento del cattolicesimo sull'ebraismo e gli ebrei. Il Papa che anche di recente ha denunciato la ricorrente tentazione di separare, anzi, di contrapporre il Nuovo e l'Antico Testamento. E invece, ricordava, Gesù è diventato «un autentico figlio di Israele, profondamente radicato nella lunga storia del proprio popolo». E perciò, il cristiano, se possiede una forte convinzione di ciò, non potrà più «accettare che gli ebrei in quanto ebrei siano disprezzati o, peggio, maltrattati».
Ma tutto questo, e cioè che Giovanni Paolo II abbia dato un impulso decisivo al processo di riavvicinamento, e quindi alla comprensione reciproca, alla collaborazione, tra ebrei e cattolici, ebbene, tutto questo può essere spiegato solo come una evoluzione conseguente al Concilio Vaticano II? Come una tappa obbligata dopo la dichiarazione Nostra Aetate, che aveva cancellato l'accusa di deicidio, e ripudiato il secolare "insegnamento del disprezzo", ricordando e riproponendo il "legame spirituale" che unisce indelebilmente cristianesimo ed ebraismo.
In Varcare la soglia della speranza il Papa ha scritto: «Dietro le parole della dichiarazione conciliare sta l'esperienza di molti uomini, sia ebrei sia cristiani. Sta anche la mia esperienza personale sin dai primissimi anni della mia vita nella città natale». Ecco: deve pur significare qualcosa - sul piano provvidenziale e non solamente su quello delle coincidenze - che l'artefice della svolta nel dialogo della Chiesa cattolica con i figli di Israele sia stato un Papa per il quale, da giovane, da ragazzo, la convivenza con gli ebrei era storia di tutti i giorni. Wadowice, dove Karol Wojtyla è nato ed è rimasto fino ai 18 anni, era una cittadina di diecimila abitanti, di cui tremila ebrei. E vivevano, cattolici ed ebrei, in un clima di serenità, senza conflitti.
Karol alloggiava in una casa il cui proprietario, Balamut, era ebreo. Ebrea era Ginka Beer, più grande di un paio d'anni, che abitava al piano di sopra, e che, per prima, lo avvicinò al teatro. Ebrei erano molti compagni di scuola, come Jerzy Kluger, grande amico ancora oggi; e poi Zygmunt Selinger, Leopold Zweig; e Poldek Goldberger, che giocava a pallone da portiere, come Wojtyla.
Il futuro Papa, così, ha conosciuto l'ebraismo dal di dentro. Attraverso una quotidianità fatta di amicizia, di stima e tolleranza reciproca. Attraverso la conoscenza di tante persone. Ma anche sul piano religioso, spirituale. In parrocchia, durante la funzione serale, era sempre colpito dal canto del salmo 147, quello dell'invito a Gerusalemme a glorificare il Signore perché ha rafforzato le sbarre delle sue porte, ha benedetto i suoi figli. Molti anni dopo, da Papa, ricorderà: «Ambedue i gruppi religiosi, cattolici ed ebrei, erano uniti, suppongo, dalla consapevolezza di pregare lo stesso Dio. Nonostante la diversità del linguaggio, le preghiere nella Chiesa e nella Sinagoga si basavano in considerevole misura sugli stessi testi».
C'è poi un secondo aspetto, per spiegare quelle che potremmo chiamare le "radici" ebraiche di Giovanni Paolo II. E anche qui, alla luce della sua storia personale, in particolare del periodo giovanile. Ed è l'aver vissuto da vicino, pur senza poterne conoscere l'esatta realtà e le vere dimensioni, la grande tragedia del popolo ebraico, la Shoah. All'origine della quale c'era l'orribile disegno hitleriano. La "soluzione finale", com'era stato chiamato il piano per far sparire, annientandola, la razza ebraica dall'intero continente europeo.
Ricordava il Papa, sempre in Varcare la soglia della speranza: «Poi venne la seconda guerra mondiale, con i campi di concentramento e lo sterminio programmato. In primo luogo lo subirono proprio i figli e le figlie della nazione ebraica, soltanto perché erano ebrei. Chiunque viveva allora in Polonia venne, anche solo indirettamente, in contatto con tale realtà. Questa fu, dunque, anche la mia esperienza personale, un'esperienza che ho portato dentro di me fino ad oggi».
Karol Wojtyla - che in quella bufera ha perduto molti dei suoi amici ebrei - ha perciò conosciuto direttamente, in prima persona, fino a che punto potesse arrivare l'odio, il disprezzo dell'uomo, nel nome di una ideologia folle, omicida. Ha conosciuto gli abissi dell'ingiustizia, della violenza, dell'oppressione di un intero popolo. E questo può spiegare molte cose di un Papa che ha dedicato la prima enciclica, "Redemptor hominis", alla causa dell'uomo, alla sua dignità, alle minacce contro di lui, ai suoi diritti inalienabili. Un Papa che durante il primo ritorno in Polonia, nel giugno del 1979, quando è arrivato ad Oswiecim (Auschwitz) ha sentito il bisogno di dire pubblicamente: «Non potevo non venire qui!».
Solo un Papa come lui, figlio di una nazione che aveva anch'essa sperimentato tragicamente la barbarie della guerra e dei campi di sterminio nazisti, che anzi è stata accomunata nel martirio al popolo ebraico, a quei poveri sei milioni di morti, solo un Papa come lui, parlando della Shoah, dell'Olocausto, ai rappresentanti della comunità ebraica polacca, a Varsavia, ha potuto dire di aver avuto «un particolare rapporto con tutto questo», perché insieme con essi aveva «vissuto in un certo senso tutto ciò qui, su questa terra». Solo un Papa come lui, che proprio nella memoria storica, nel retaggio culturale della sua Patria, ha trovato l'ispirazione per pronunciare sull'ebraismo parole nuove, parole profondamente diverse da quelle dette per secoli dalla Chiesa cattolica, solo un Papa come lui ha potuto scrivere in questi termini agli "amati fratelli ebrei" per il 50° dell'insurrezione del Ghetto di Varsavia: «Come non essere accanto a voi, per ricordare nella preghiera e nella meditazione un così doloroso anniversario? Siatene certi: non sostenete da soli la pena di questo ricordo».
Insomma, nessuno vuole dimenticare la storia passata. Ma che il peso di questa storia non impedisca intanto di sviluppare il dialogo; e, soprattutto, di affrontare e risolvere, sul piano culturale ma prima ancora su quello religioso, il pesantissimo "contenzioso" che ancora rimane. E cioè, da parte degli ebrei, la presunzione, già così difficile da rimuovere nel ricordo collettivo, che ci sia stato in qualche modo anche il cristianesimo all'origine delle tante tragedie che essi hanno vissuto. E, dall'altra parte, il trauma del mondo cristiano, diviso tra la persuasione di non aver avuto responsabilità dirette nella Shoah e la drammatica ammissione, fatta dall'episcopato tedesco e ora da quello francese, di non essere stato al fianco del popolo ebraico nel momento del martirio.
Ed ecco perché - come sostiene Giovanni Paolo II - è venuto il momento che ebrei e cristiani riscoprano e facciano fruttificare il comune patrimonio spirituale. Per poter camminare assieme. E assieme lottare contro l'antisemitismo. E collaborare per la difesa dei diritti umani, per la giustizia sociale, la pace. E poter così, giorno dopo giorno, sperimentare l'essere fratelli, membri di un'unica famiglia. Testimoniando, finalmente riconciliati, la stessa speranza nell'attesa del «Dio che viene».
| Home | | inizio pagina |